 C’è stato un tempo, un lungo tempo, in cui dovevo andare in Portogallo almeno due/tre volte l’anno. Era la mia seconda patria. Colpa, anzi merito, di Saramago e Pessoa. E pure di Rui Costa. Lo conosco benissimo da Nord a Sud. Una delle cose che più amavo era l’aperitivo. Entrada, cioè il formaggio lusitano, oppure un po’ di sardine. O anche solo le olive. E il vinho verde. A volte anzi sceglievo Porto bianco, quello secco, perfetto per cominciare la serata.
C’è stato un tempo, un lungo tempo, in cui dovevo andare in Portogallo almeno due/tre volte l’anno. Era la mia seconda patria. Colpa, anzi merito, di Saramago e Pessoa. E pure di Rui Costa. Lo conosco benissimo da Nord a Sud. Una delle cose che più amavo era l’aperitivo. Entrada, cioè il formaggio lusitano, oppure un po’ di sardine. O anche solo le olive. E il vinho verde. A volte anzi sceglievo Porto bianco, quello secco, perfetto per cominciare la serata.
Il vinho verde non è uno vino specifico. Vuol dire solo vino verde, cioè giovane, e può essere bianco, rosato o rosso. A volte anche leggermente mosso. Va da sé che il vinho verde “vero” è – per me? – solo bianco. Vitigni Alvarinho e/o Loureiro, vendemmia anticipata, poco alcol. Tanta acidità e quando va bene bella mineralità. Da servire freddo: decisamente freddo, a costo di perdere qualcosa a livello olfattivo. A volte, anzi spesso, sono vini perfettini e tutti uguali. Ma se sei in Portogallo, e stai bene, ti piacciono lo stesso. In alcuni casi, invece, ti capita proprio die esultare. Per esempio con questo Quinta da Palmirinha. Io ho provato l’annata 2017, ma è buono sempre. 11,5 gradi, quindi pochi, che per il vinho verde è requisito essenziale. Ha carattere, lunghezza tutta sua e personalità spiccata. Bevibilissimo, con quel naso “verde” che vira poi per aroma di bocca su arachidi e mandorla. Puoi finirlo da solo e non accorgertene. Preso a Les Caves de Pyrene. Scopro da Jacopo Cossater su Intravino ulteriori pregi da questa azienda che vi consiglio senza indugio: “Il produttore, Fernando Paiva, 74 anni, è stato uno dei pionieri della biodinamica portoghese: certificato biologico dall’inizio, dal 2001, ha iniziato poco dopo a interessarsi ai principi steineriani arrivando a una conversione completa nel 2007 (ancora oggi è una delle pochissime cantine certificate Demeter del Paese). Ex professore di storia, ha ereditato 3,5 ettari di vigneto dai suoi genitori, in parte a Bouça Chã e in parte a Amarante. La cantina si trova appena fuori il centro abitato di Lixa, nel nord-ovest del Portogallo, nello stesso distretto della città di Porto e della zona in cui nascono i suoi vini più celebri, la valle del fiume Douro. Un bianco prodotto solo a partire da uve di loureiro (insieme all’alvarinho la varietà a bacca bianca più rilevante della zona), vinificato e lasciato maturare per poco meno di un anno in sole vasche di acciaio prima di una sosta di circa 6 mesi in bottiglia. Un vino che spiazza anche per il prezzo: difficile trovarlo a scaffale, in enoteca, sopra agli 8 euro“. In Italia si trova a un prezzo superiore (sui 12-15). Ma li vale tutti. Ah, il vinho verde (quando è buono davvero).
Archive for the ‘Recensioni’ Category
Ah, il vinho verde
martedì, Giugno 11th, 2019Incontro con Andrea Scanzi (e il vino)
mercoledì, Novembre 5th, 2014 Pubblico integralmente l’intervista che ha realizzato Giorgio Demuru per l’AIS Sardegna: il mio rapporto con il vino, la scelta vegetariana, la predilezione per i bianchi, i vini naturali e la resistenza, l’evoluzione del gusto e il Portogallo. Eccetera.
Pubblico integralmente l’intervista che ha realizzato Giorgio Demuru per l’AIS Sardegna: il mio rapporto con il vino, la scelta vegetariana, la predilezione per i bianchi, i vini naturali e la resistenza, l’evoluzione del gusto e il Portogallo. Eccetera.
“Una delle due date isolane dello spettacolo “Le cattive strade”, lo scorso 10 ottobre a Porto Torres, è stata l’occasione per incontrare Andrea Scanzi, qui nella veste di autore e attore teatrale, ma giornalista e scrittore di grande talento e dai tanti interessi, tra cui il vino. Andrea è Sommelier AIS e Degustatore Ufficiale e, soprattutto, autore di Elogio dell’invecchiamento e Il vino degli altri, due volumi divenuti imprescindibili per professionisti, tecnici e semplici appassionati. Ne abbiamo approfittato per scambiare due chiacchiere sul nostro amato universo “vino & dintorni”.
Ciao Andrea, partiamo da una domanda banale: cosa ti spinse, a suo tempo, ad iscriverti ai corsi AIS?
“Quello che mi spinge quasi sempre: il desiderio di saperne di più. Amavo il vino, ma detestavo il non conoscerlo quanto volessi. Non sopportavo che, una volta al ristorante, fossi in totale balìa del proprietario. Non ne potevo più di dire “Scelga lei” o di sparare a caso un “Mi dia un Dolcetto d’Alba”. Volevo imparare e le 45 lezioni AIS sono state decisive. Non bastano per sapere, ma costituiscono la partenza migliore. Mentre stavo terminando il terzo livello AIS ad Arezzo, nacque – con il grande Edmondo Berselli e Beppe Cottafavi di Mondadori – l’idea di scrivere un libro semiserio su vino e sommelier. Era il 2007 e di lì a poco sarebbe uscito Elogio dell’invecchiamento, un successo che dura ancora oggi e continua a stupirmi”.
Negli ultimi tempi è notevolmente aumentata la tua esposizione mediatica, in ambiti diversi (politica, sport, musica, etc.) e senza disdegnare i contesti “pop”, assecondando quella che tu stesso hai definito “bulimica curiosità culturale”. In questa postmoderna ronde di contaminazioni, che posto occupa attualmente il vino?
“Occupa il posto dell’amico che non tradisce mai e sa divertirti, ascoltarti e comprenderti. Per un po’ ho smesso di scrivere di vino, e anche adesso lo faccio meno di prima per mancanza di tempo, ma per certi versi è un bene: mi permetterà di mantenere sempre l’approccio del curioso informato. Quando una passione resta un hobby e non diventa un lavoro, puoi permetterti di conservare quella leggerezza cazzara che aiuta a non prenderti troppo sul serio. Con il vino mi riesce, in altri ambiti forse no”.
Operando spesso a contatto con la gente, ho riscontrato un crescente interesse nei confronti della conoscenza “consapevole” del vino. Pensi che il pubblico degli appassionati sia ancora catalogabile come – ironicamente – hai fatto nei tuoi libri o hai notato una sorta di evoluzione?
“L’ironia, nei miei libri, era molto affettuosa. Sulla falsariga della imitazione del sommelier realizzata da Antonio Albanese. C’è stata una evoluzione nella conoscenza, che ha senz’altro portato a una maggiore consapevolezza. Permangono approcci pallosissimi, da cattedratici che tromboneggiano con l’aria di chi sta decidendo le sorti del mondo, ma continuo a pensare che il mondo del vino sia pieno – più di qualsiasi altro microcosmo – di personaggi straordinari: figure intimamente letterarie, che sono uscite da qualche pagina ispirata e chiedono in qualche modo di essere nuovamente raccontate. Avamposti utopici di resistenza enoica. Penso ad alcuni esponenti del cosiddetto “vino vero” e “naturale”, un movimento che nel 2007 era quasi agli inizi, ma non penso solo a loro”.
Mi permetto una metafora politica: in un contesto generale di “vini-PD” (cioè omologati e “piacioni”) quanto pensi possa essere ampio lo spazio per quelli che tu hai definito anche adesso “avamposti di resistenza enoica”?
“C’è sempre spazio per l’opposizione, per la resistenza, per la diversità. Anzi: più emerge un pensiero massificato (anche se “pensiero” è una parola troppo forte se applicata al renzismo) e più si verifica una reazione uguale e contraria. Da qui il bisogno di percorsi diversi, in questo caso di vini non omologati. Parliamo e parleremo sempre di una minoranza, ma non così esigua come si crede”.
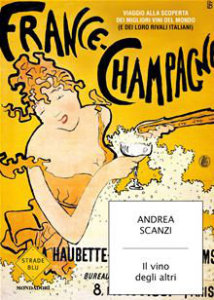 Nella settimana che ha preceduto le due date teatrali, hai avuto modo di girare l’isola, in modalità random: che idea ti sei fatto, in generale e – nello specifico – delle realtà vitivinicole che hai potuto osservare da vicino?
Nella settimana che ha preceduto le due date teatrali, hai avuto modo di girare l’isola, in modalità random: che idea ti sei fatto, in generale e – nello specifico – delle realtà vitivinicole che hai potuto osservare da vicino?
“Ho trovato una regione straordinaria. Ho viaggiato su e giù per la Sardegna, divertendomi come un bambino. Ogni suo angolo racchiude uno splendore a cui è impossibile resistere. In termini enoici, gli incontri che più mi hanno colpito sono stati quelli con Alessandro Dettori in Romangia (Tenute Dettori) e con Gianfranco Manca poco fuori Nurri (Panevino). Del primo, che mi ha ospitato due volte a pranzo, amo in particolare la cultura, la voglia sana di emergere e i bianchi; del secondo, con cui ho cenato una sera, apprezzo l’approccio rigoroso, la chiarezza con cui persegue i suoi principi (oserei dire filosofici) e i rossi, tra i pochi ormai che riesco a bere con piacere raro”.
Hai più volte dichiarato che, negli anni, le tue preferenze in ambito vinicolo sono, ovviamente, cambiate, in un graduale processo di affinamento del gusto che ti ha portato a privilegiare bianchi “verticali” e bollicine, con qualche significativa eccezione, come gli eleganti rossi ottenuti da Nebbiolo, Pinot Noir e affini. E’ un percorso abbastanza comune tra noi dell’ambiente, anche se non scontato. Pensi possa diventare un percorso condiviso anche dal grande pubblico, una volta tramontata – per fortuna – la moda dei vini palestrati e, per semplificare, di impronta USA?
“Ognuno ha la sua storia e non puoi pretendere che una persona che ascolta solo Laura Pausini si innamori un giorno di John Coltrane. C’è chi si ferma alle prime emozioni e chi invece è bruciato da un fuoco interiore che lo porta a inseguire sempre nuove strade. All’inizio il vino morbido, e magari con residuo zuccherino, piace a tutti. Poi cerchi i tannini. Poi ti innamori del “vino verticale”: dell’eleganza, del fascino. E dunque Champagne, Riesling, Pinot Noir. Ma non capita a tutti: quando esco con una donna, spesso mi dice che “beve solo rossi” oppure “bianchi profumati”. A quel punto, se le fai provare subito un orange wine o un Pas Dosé, corri un rischio enorme. Vale anche per un familiare, un collega, un amico. Per apprezzare determinate tipologie, ancor più se naturali, occorre avere un interesse spiccato per il vino ed essere disposti a intraprendere un percorso. Non tutti ne hanno voglia e va bene così. Allo stato attuale bevo bianchi al 90% e rossi al 10%. Il requisito che più cerco, prim’ancora dell’eleganza, è la bevibilità. Adoro i vini glou glou e detesto i vinoni che stancano”.
Hai sempre avuto un debole per il Portogallo, paese che, in termini enologici, dalle nostre parti è stato spesso associato ai terribili Lancers e Mateus o, al massimo, alle pallide versioni base del Porto Ruby. Invece, Porto e Madeira sono delle grandissime realtà quasi misconosciute.
“Il Portogallo resta un amore eterno, però più geografico e letterario. Per me il Portogallo è Pessoa, è Saramago, è Lobo Antunes. E’ Lisbona, l’Alentejo, è il vento che non si stanca mai di agitare l’Oceano. I vini vengono dopo. Alcuni Porto sono strepitosi, soprattutto i Vintage e gli LBW, ma qualche anno fa ne bevevo di più. Vale ancora di più per i Madeira: è una realtà dalle potenzialità notevoli e poco conosciute in Italia, hai ragione, ma è raro che beva “vini da meditazione”. Una delle pochissime eccezioni è il Sol di Cerruti”.
Negli ultimi anni sei diventato vegetariano. Hai raccontato che, nella scelta, fu decisiva la lettura del libro Se niente importa di Jonathan Safran Foer (al quale aggiungerei Il dilemma dell’onnivoro di Michael Pollan, di cui parleremo a breve su questa pagine, nella rubrica “Letto per voi”). Ti chiedo: nella decisione ha pesato di più l’attaccamento assoluto alle tue amate Labrador o il desiderio di ammantare di consapevole e coerente rigore anche le tue scelte alimentari?
 “La scelta vegetariana, e ormai quasi vegana, è molto mia. Ne vado fiero, ma non cerco proseliti e provo un fastidio vivissimo per i carnivori che fanno battute idiote o ti incolpano di essere vegetariano “però hai il giubbotto di pelle”. Ognuno faccia la sua vita e nessuno dia lezioni. So di essere oltremodo perfettibile e contraddittorio, come tutti del resto, ma incidere “4” sul mondo animale mi fa stare meglio di quando incidevo “7” o “9”. Certo, potrei incidere “0” e vestire solo in jeans e tela, ma per ora mi va bene così. Sono vegetariano dal 2001 e dall’inizio di quest’anno ho praticamente tagliato tutto ciò che è grasso, ancor più se proveniente dal mondo animale. Per un mese ho vissuto solo di frutta, verdura e legumi. Poi ho fatto un bilancio e mi sono reso conto che l’unica cosa che mi mancava era il vino: così ho ricominciato a bere vino. E ho continuato a non mangiare – e bere – il resto. Niente birre, niente superalcolici se non un whisky o un distillato come si deve ogni tanto. Pane e pasta quasi mai, men che meno a cena. Formaggio assai di rado. Non amo neanche le uova, le salse e i dolci, quindi chi mi invita a cena – a pranzo mangio pochissimo – se la cava con una verdura grigliata e qualche legume (tanto il vino lo porto io). Al limite, ma solo quando ceno fuori e sono costretto perché non c’è proprio altro, in casi eccezionali mangio un po’ di pesce. Ma preferisco di no e chi mi conosce lo sa. Ormai sono diventato un esperto di seitan, tofu, mopur e tempeh. Sto bene così, sia da un punto di vista etico che salutistico: ho perso 15 chili dal febbraio scorso. Oltre ai libri di Safran Foer e Pollan, mi ha certo condizionato vivere con due labrador. Amo gli animali e, finché posso, non intendo nuocere loro in alcun modo. Spesso vado a cavallo: ecco, l’idea di mangiare carne di cavallo la trovo (personalmente) inconcepibile. E per me vale lo stesso per un coniglio, un capretto o un maiale. Lo so, dovrei evitare anche il tonno una volta al mese e il pezzo di formaggio con caglio animale ogni morte di Papa, ma l’ho già detto: sono perfettibile, ho margini di miglioramento e mi piaccio così. Neanche poco, peraltro”.
“La scelta vegetariana, e ormai quasi vegana, è molto mia. Ne vado fiero, ma non cerco proseliti e provo un fastidio vivissimo per i carnivori che fanno battute idiote o ti incolpano di essere vegetariano “però hai il giubbotto di pelle”. Ognuno faccia la sua vita e nessuno dia lezioni. So di essere oltremodo perfettibile e contraddittorio, come tutti del resto, ma incidere “4” sul mondo animale mi fa stare meglio di quando incidevo “7” o “9”. Certo, potrei incidere “0” e vestire solo in jeans e tela, ma per ora mi va bene così. Sono vegetariano dal 2001 e dall’inizio di quest’anno ho praticamente tagliato tutto ciò che è grasso, ancor più se proveniente dal mondo animale. Per un mese ho vissuto solo di frutta, verdura e legumi. Poi ho fatto un bilancio e mi sono reso conto che l’unica cosa che mi mancava era il vino: così ho ricominciato a bere vino. E ho continuato a non mangiare – e bere – il resto. Niente birre, niente superalcolici se non un whisky o un distillato come si deve ogni tanto. Pane e pasta quasi mai, men che meno a cena. Formaggio assai di rado. Non amo neanche le uova, le salse e i dolci, quindi chi mi invita a cena – a pranzo mangio pochissimo – se la cava con una verdura grigliata e qualche legume (tanto il vino lo porto io). Al limite, ma solo quando ceno fuori e sono costretto perché non c’è proprio altro, in casi eccezionali mangio un po’ di pesce. Ma preferisco di no e chi mi conosce lo sa. Ormai sono diventato un esperto di seitan, tofu, mopur e tempeh. Sto bene così, sia da un punto di vista etico che salutistico: ho perso 15 chili dal febbraio scorso. Oltre ai libri di Safran Foer e Pollan, mi ha certo condizionato vivere con due labrador. Amo gli animali e, finché posso, non intendo nuocere loro in alcun modo. Spesso vado a cavallo: ecco, l’idea di mangiare carne di cavallo la trovo (personalmente) inconcepibile. E per me vale lo stesso per un coniglio, un capretto o un maiale. Lo so, dovrei evitare anche il tonno una volta al mese e il pezzo di formaggio con caglio animale ogni morte di Papa, ma l’ho già detto: sono perfettibile, ho margini di miglioramento e mi piaccio così. Neanche poco, peraltro”.
Hai più volte confessato di essere un toscano “atipico”, dal cuore (enoico) spostato decisamente verso il Piemonte. Tra poco, proprio a Torino, ci sarà il Congresso Nazionale AIS: pensi di riuscire a trovare qualche ritaglio di tempo per tuffarti nelle degustazioni dei grandi vini piemontesi?
“Confermo di essere un toscano enoicamente atipico, a un ottimo Sangiovese preferirò sempre un ottimo Nebbiolo. Riguardo al tuo invito: mi piacerebbe e ti ringrazio, ma fra teatro, tivù e vita privata viaggio già anche troppo. La mia auto non ha neanche undici mesi e il contachilometri dice già 60mila. Per questo ho smesso di partecipare a dibattiti, convegni e degustazioni (pubbliche: quelle private eccome se le frequento). Quando posso, sto molto felicemente a casa: focolare acceso, una bella donna accanto, due labrador fighissime a fare la guardia (si fa per dire) e la bottiglia giusta di vino. Difficile chiedere di più” (AIS-Sardegna, grazie a Giorgio Demuru, 4 novembre 2014)
Cannavacciuolo salverà il mondo (Cucine da incubo)
venerdì, Luglio 12th, 2013 “Questi cucinano con la merda, cazzo”. Il vocione di Antonino Cannavacciuolo, totemico chef napoletano 38enne, introduce la nona e penultima puntata di Cucine da incubo. Ore 21.55, FoxLife, 233mila spettatori (poco sotto l’1% di share). Prima stagione italiana. La versione originale, Ramsay’s Kitchen Nightmares, è andata in onda in Inghilterra dal 2004 al 2009. Il protagonista era Gordon Ramsay, presente più o meno in 312 reality gastronomici.
“Questi cucinano con la merda, cazzo”. Il vocione di Antonino Cannavacciuolo, totemico chef napoletano 38enne, introduce la nona e penultima puntata di Cucine da incubo. Ore 21.55, FoxLife, 233mila spettatori (poco sotto l’1% di share). Prima stagione italiana. La versione originale, Ramsay’s Kitchen Nightmares, è andata in onda in Inghilterra dal 2004 al 2009. Il protagonista era Gordon Ramsay, presente più o meno in 312 reality gastronomici.
Cannavacciuolo è un cuoco molto bravo. Dal 1999 è titolare e gestore, con la moglie Cinzia Primatesta, del lussuoso Ristorante Hotel “Villa Crespi” a Orta San Giulio. Due stelle Michelin, tre forchette Gambero Rosso. Una star, che arriva nel luogo del delitto guidando un vespone, le cui sospensioni ne accettano con stoico eroismo il nobile peso.
Cucine da incubo si distingue da Master Chef per una Weltanschauung più illuminista. Master Chef è un Full Metal Jacket alla vaccinara, cattivista, in cui i candidati vanno in crisi di nervi se solo qualcuno ne critica l’impiattamento. La triade Bastianich-Barbieri-Cracco incarna un Sergente Hartman al cubo che scudiscia i peccatori senza pietà, sciorinando avvincenti dissertazioni sul potere lisergico dei fagioli zolfini. Cracco, per esempio, è un perfetto incrocio tra Lorenzo Lamas e Chuck Norris, condividendone peraltro la fiera monoespressività. Iperboli, esagerazioni e una sola certezza: se sbagli julienne, sei fuori. E non ci sarà salvezza. Né per te, né per il Pianeta.
Cucine da incubo, no. Qui il sottotesto è Rocky IV, laddove il protagonista tumefatto biascicava rivolto a Gorbaciov: “Io credo che se noi possiamo cambiare, tutto il mondo può cambiare!”. Cannavacciuolo è il Rocky dei talent culinari. Un Balboa ruvido, però buono. Il cotè di Cucine da incubo è la favola. E’ Frank Capra. C’è sempre il lieto fine. L’Inferno diventerà Paradiso e il merito sarà di Antonino, che a fine puntata non griderà “Adriana!” ma mostrerà a cuochi sfigatelli le agognate porte della percezione.
Rocky Cannavacciuolo dovrebbe essere sadico, ma non gli viene proprio. Nelle foto di scena è ritratto con posa da incazzoso e il coltellaccio stile Dexter, ma tutti sanno che uno così al massimo può pugnalare una lasagna. La trama di Cucine da incubo è semplice: Antonino deve salvare un ristorante in crisi. Una volta è a Gaggiano, quella dopo a Frascati. Nella puntata di mercoledì diffondeva il verbo a Roma. Ristorante Le Lanterne. La proprietaria era una giovane polacca, lo chef un sardo, l’aiutocuoco un orientale. Due camerieri in sala. Situazione disperata. Tutti parlano male di tutti, i clienti scarseggiano e quei pochi si lamentano. Qua, forse volendo e forse no, il programma si rivela un discreto spaccato della società, mostrandone ipocrisia e perfidia. Se il piatto non è buono, il cuoco incolpa sempre gli altri: chi ha preso la comanda, il personale che scarseggia, il cliente che non se ne intende. Pure se colto in flagrante, è pronto a giurare che il pesto l’ha fatto davvero lui in persona (sebbene la telecamera mostri la scena in cui lo toglie dal vasetto comprato al supermercato) e che i paccheri non erano affatto precotti (anche se dopo due minuti il piatto era già pronto).
 E Cannavacciuolo? Egli è il Salvatore. Il Guru. Il Messia. Egli non sbaglia. Mai. Egli è la Luce. Il plot si ripete, senza abbondare in veridicità. Antonino arriva e prova i piatti, trovandoli puntualmente una chiavica: il riso fa schifo, la carne fa schifo, il menu fa schifo. Fa tutto schifo, tranne lui. Poi commenta con indicibile disgusto – e qualche parolaccia buttata là come mantecatura su un’umanità irredimibile – l’arredamento. Al mattino successivo ispeziona la cucina del locale, trovandola non di rado più impresentabile di un bagno chimico dopo un concerto degli Ac/Dc. Arriva quindi il punto della catechesi, in cui Cannavacciuolo schiaffeggia con amore paterno il volgo – cioè cuochi e sottocuochi – mostrandogli la via e insegnandogli piatti mirabili ma in fondo facili. E’ qui che si verifica l’agnizione: i peccatori, rapiti dalla bravura del titanico Antonino, si innamorano dei suoi pomodorini su fondo di burrata o delle cozze adagiate su letto di fagioli borlotti polverizzati.
E Cannavacciuolo? Egli è il Salvatore. Il Guru. Il Messia. Egli non sbaglia. Mai. Egli è la Luce. Il plot si ripete, senza abbondare in veridicità. Antonino arriva e prova i piatti, trovandoli puntualmente una chiavica: il riso fa schifo, la carne fa schifo, il menu fa schifo. Fa tutto schifo, tranne lui. Poi commenta con indicibile disgusto – e qualche parolaccia buttata là come mantecatura su un’umanità irredimibile – l’arredamento. Al mattino successivo ispeziona la cucina del locale, trovandola non di rado più impresentabile di un bagno chimico dopo un concerto degli Ac/Dc. Arriva quindi il punto della catechesi, in cui Cannavacciuolo schiaffeggia con amore paterno il volgo – cioè cuochi e sottocuochi – mostrandogli la via e insegnandogli piatti mirabili ma in fondo facili. E’ qui che si verifica l’agnizione: i peccatori, rapiti dalla bravura del titanico Antonino, si innamorano dei suoi pomodorini su fondo di burrata o delle cozze adagiate su letto di fagioli borlotti polverizzati.
Il locale, sulla via della redenzione, organizza a questo punto un pranzo gratis per riconquistare la clientela e provare i nuovi piatti. Si notano dei miglioramenti, ma è presto per il lieto fine e qualche cliente (pur mangiando a scrocco) protesta. Cannavacciuolo Balboa, con la pazienza di Giobbe e le manone da Bud Spencer, sospira ma conosce la strada. Così cambia l’arredamento, trasformando una bettola cafonal in un’osteria dei sogni. La proprietaria piange, il cuoco piange, i camerieri piangono. Un tripudio di lacrime, un’esondazione di commozione. Si ode far festa: la Terra resterà in asse. Rocky ha vinto anche stavolta e tutti vivranno felici e contenti. Tranne Antonino. Il quale, come ogni eroe, ha sempre l’aria malinconica. La gioia suprema gli è negata. Rocky è troppo impegnato a cancellare le malefatte altrui per sorridere, e infatti è già in sella sopra il destriero-vespone. Verso nuove frontiere e cucine. Quando il sole sorge, non importa se sei un leone o una gazzella. L’importante, se hai un ristorante, è che il locale te lo rilanci Cannavacciuolo. Altrimenti è un casino.
(Il Fatto Quotidiano, 12 luglio 2013)
Ansonaco Carfagna 2010 – Vigneto Altura
domenica, Giugno 2nd, 2013 Di questa Ansonaca dell’Isola del Giglio, storico quanto raro vitigno autoctono, Arnaldo Rossi della Taverna Pane e Vino di Cortona mi parla da molto tempo.
Di questa Ansonaca dell’Isola del Giglio, storico quanto raro vitigno autoctono, Arnaldo Rossi della Taverna Pane e Vino di Cortona mi parla da molto tempo.
L’ho (ri)provato martedì scorso. E confermo tutto il buono che ho sentito dire su questo bianco di Vigneto Altura.
Annata 2010, Famiglia Carfgana. In Rete si trova attorno ai 30 euro, in cantina poco sopra i 20.
Non fa macerazione, ma a guardare il colore (e poi a sentirlo) non sembrerebbe. Gradazione (mi pare) di 13.3 gradi. Va aperto con un certo anticipo, ci mette un po’ ad aprirsi.
La temperatura di servizio dev’essere da rosso, o giù di lì. Non punitelo con le basse temperature, lo uccidereste.
Niente diserbanti, concimi chimici, insetticidi, veleni. Vino naturale a tutti gli effetti, Ansonica (o Ansonica, Inzolia: chiamatelo come volete) in purezza.
Il primo bicchiere mi ha colpito, il secondo stregato. Spicca per bevibilità, equilibrio, eleganza e complessità.
La tipicità è particolarmente spiccata. Uno di quei vini rari che sa restituire tutta la storia della sua terra.
Non è un vino particolarmente economico, ma i soldi che richiede li vale tutti.
Applausi. E parecchi.
Gaber (se fosse Gaber) in Langa
mercoledì, Gennaio 23rd, 2013 Domani, giovedì 24 gennaio 2013, il mio spettacolo Gaber se fosse Gaber vivrà la sua 54esima replica (qui tutte le date) in un luogo per me particolare: Alba.
Domani, giovedì 24 gennaio 2013, il mio spettacolo Gaber se fosse Gaber vivrà la sua 54esima replica (qui tutte le date) in un luogo per me particolare: Alba.
Lì, oltre a un pezzo di cuore, ho molti amici. Sarebbe bello rivederli a teatro (e so che molti ci saranno).
Il luogo è il Teatro Sociale, 600 posti. Si va verso il tutto esaurito, ma c’è ancora disponibilità.
Ci sarà una bella mostra sul Signor G (del grande Guido Harari). Ci sarà una degustazione. Ci saranno i monologhi e le canzoni.
Vi aspetto. Se vi va.
Il magico mondo dei vini
venerdì, Dicembre 28th, 2012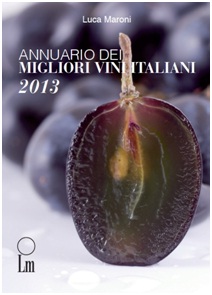 Il tomo non passa inosservato. Milletrecento pagine, 49 euro. E’ l’Annuario dei Migliori Vini Italiani 2013. Esce dal 1993. Lo cura Luca Maroni, profeta del vino piacione e ciccione. Non è l’unica guida che esce a fine anno. Ci sono DuemilaVini dell’Associazione Italiana Sommeliers. La SlowWine. Il Gambero Rosso. L’Espresso. Ognuna ha il suo target. Un tempo, se ricevevi i Tre Bicchieri o i Cinque Grappoli, potevi vendere quel vino a prezzi inauditi: qualcuno lo avrebbe comprato. Meglio ancora se, a benedire il tutto, fosse spuntato un Robert Parker o un James Suckling, demiurghi del vino sempre uguale a se stesso. Oggi molto è cambiato. Per la crisi e perché la Rete ha rivoluzionato la comunicazione. Il blogger, spesso, influenza più del cartaceo tromboneggiante. Consultando siti e guide è possibile evitare fregature. Ogni vino ha la sua caratteristica, ogni azienda la sua impostazione. Ecco un vademecum breve.
Il tomo non passa inosservato. Milletrecento pagine, 49 euro. E’ l’Annuario dei Migliori Vini Italiani 2013. Esce dal 1993. Lo cura Luca Maroni, profeta del vino piacione e ciccione. Non è l’unica guida che esce a fine anno. Ci sono DuemilaVini dell’Associazione Italiana Sommeliers. La SlowWine. Il Gambero Rosso. L’Espresso. Ognuna ha il suo target. Un tempo, se ricevevi i Tre Bicchieri o i Cinque Grappoli, potevi vendere quel vino a prezzi inauditi: qualcuno lo avrebbe comprato. Meglio ancora se, a benedire il tutto, fosse spuntato un Robert Parker o un James Suckling, demiurghi del vino sempre uguale a se stesso. Oggi molto è cambiato. Per la crisi e perché la Rete ha rivoluzionato la comunicazione. Il blogger, spesso, influenza più del cartaceo tromboneggiante. Consultando siti e guide è possibile evitare fregature. Ogni vino ha la sua caratteristica, ogni azienda la sua impostazione. Ecco un vademecum breve.
Vino Chic
Il Vino-status symbol, lo Swarovski di Enolandia. Molto di moda nei Novanta, ora di meno. Splendido all’esame visivo, profumi ammiccanti al naso, struttura grassottella (gli espertoni direbbero “opulenta”). Più morbido che fresco, tannini smussati. Barrique in evidenza, come attestano i famigerati “sentori di vaniglia”. La patria eletta è Bordeaux, di cui Bolgheri è dépendance italica (Sassicaia, Ornellaia). Vitigni: Merlot (l’uva più conformista del globo), Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Spesso in uvaggio, di rado in purezza (eccezione di pregio è il Paleo Le Macchiole). Adorato dal Gambero Rosso e Luca Maroni, detestato dagli alternativi. Rigorosamente carissimo.
Vino Fighetto
Simile al precedente, ma con una ancor più dichiarata aspirazione a piacere. Buono al primo sorso, stucchevole al secondo. Se fosse musica, sarebbe un disco commerciale (tipo Justin Bieber). L’esempio più evidente è il Supertuscan, Frankenstein multiforme che unisce più vitigni (di solito per “ingentilire” il Sangiovese). Bello senz’anima, è adorato dal turismo anglosassone. Il Vino Fighetto si annida anche in zone di tradizione antica, come Montalcino e Montepulciano (ma pure Langhe, vedi Gaja). Le eccezioni non mancano. Cercate un Sangiovese autentico? Montevertine. Un Nebbiolo inusuale? La Chiavennasca di Ar.Pe.Pe. Un Barolo tradizionale? Giuseppe “Citrico” Rinaldi. Un Cannonau eterno? Il Perda Rubia.
Vino Perlage
 Il perlage è la bollicina (ma dire “bollicina” non è cool). Niente raggiungerà mai i migliori Champagne, eppure i Metodo Classico (gli Champagne italiani, semplificando) sono dignitosi. Soprattutto in Trentino Alto Adige, Oltrepò Pavese, Franciacorta. Di questa ultima zona, nel bresciano, si possono consigliare la fascia alta di Ca’ del Bosco, Cavalleri, Faccoli, Ca’ del Vent. Crescente l’apprezzamento per il Pas Dosè, senza residuo zuccherino. Per gli amanti dello Champagne, risultano meno cari – e più originali – quelli prodotti da piccoli vignerons e non da grandi maisons. Nell’etichetta hanno scritto “RM” e non “NM”. A una Veuve Cliquot preferite un Larmandier-Bernier.
Il perlage è la bollicina (ma dire “bollicina” non è cool). Niente raggiungerà mai i migliori Champagne, eppure i Metodo Classico (gli Champagne italiani, semplificando) sono dignitosi. Soprattutto in Trentino Alto Adige, Oltrepò Pavese, Franciacorta. Di questa ultima zona, nel bresciano, si possono consigliare la fascia alta di Ca’ del Bosco, Cavalleri, Faccoli, Ca’ del Vent. Crescente l’apprezzamento per il Pas Dosè, senza residuo zuccherino. Per gli amanti dello Champagne, risultano meno cari – e più originali – quelli prodotti da piccoli vignerons e non da grandi maisons. Nell’etichetta hanno scritto “RM” e non “NM”. A una Veuve Cliquot preferite un Larmandier-Bernier.
Vino Supermercato
Spesso trattati con snobismo, ma il rapporto qualità/prezzo è fondamentale. E nella Grande Distribuzione Organizzata non ci si imbatte soltanto in Ronco e Tavernello (con rispetto parlando). C’è anche chi, come il boss Oscar Farinetti di Eataly, immette sugli scaffali Esselunga dei Nebbiolo validi. Un appassionato estetizzante non li comprerebbe neanche sotto tortura, ma al 90 percento del consumatore comune piacciono.
Vino Macerativo
 Detto anche “orange wine”, è il bianco che macera sulle bucce (come se fosse un rosso). Alla vista appare aranciato e un po’ torbido. Ha profumi da vino passito (se la macerazione è lunga), ma gusto secco e sapido. Non di rado strepitoso, ma inadatto ai novizi. Maestro e guru è Josko Gravner, filosofo dell’anfora. La sua Ribolla Gialla, a Oslavia, è esperienza mistica.
Detto anche “orange wine”, è il bianco che macera sulle bucce (come se fosse un rosso). Alla vista appare aranciato e un po’ torbido. Ha profumi da vino passito (se la macerazione è lunga), ma gusto secco e sapido. Non di rado strepitoso, ma inadatto ai novizi. Maestro e guru è Josko Gravner, filosofo dell’anfora. La sua Ribolla Gialla, a Oslavia, è esperienza mistica.
Vino Naturale
Lieviti indigeni, poca solforosa. Zero chimica o quasi. Non necessariamente biodinamici. I produttori sono soliti riunirsi in manifestazioni e associazioni ad hoc. Se facessero politica, sarebbero la sinistra extraparlamentare, i Cinque Stelle o gli Arancioni. Rivoluzionari eretici, in crescita numerica e qualitativa. A volte rischiano il culto della nicchia e l’onanismo dell’alternativismo. Collecapretta in Umbria, Stefano Legnani in Liguria, La Biancara in Veneto. Eccetera.
Vino Glou Glou
Immagine molto in voga in Rete, per indicare un vino quotidiano che non aspira a essere indimenticabile ma che vuol essere anzitutto bevibile. Piacevole. Digeribile (e mai caro). Il Dolcetto d’Alba di Flavio Roddolo. Il Prosecco di Casa Coste Piane. Il Lambrusco Nubilaia di Lombardini. Glou glou.
Vino Kiarostami
Nessuno, a parte Nanni Moretti, è in grado di vedere un film intero di Abbas Kiarostami senza addormentarsi. Tre ore di piani sequenza sui ciliegi non sono esattamente l’idea condivisa di divertimento e bellezza. Se però dici che Kiarostami ti piace, passi subito per cinefilo d’essai. Nel vino è lo stesso. I vitigni Kiarostami sono Riesling (Mosella anzitutto) e Pinot Noir (Borgogna rigorosamente). Nel tortuoso percorso di conoscenza enoica, che di solito comincia con i vini dolci, rappresentano l’ultimo scalino. In Italia non si adattano benissimo. I migliori Riesling e Pinot Nero si scovano in Alto Adige.
Vino buono
Non esiste. Il vino è il regno del soggettivo. Esiste il vino corretto, tecnicamente ben fatto, senza difetti. Il resto è guerra dei gusti personali. C’è chi baratterebbe il suo regno per un Vouvray della Loira e chi ci farebbe al massimo i gargarismi.
Vino Muccino
Stanno al vino come l’eiaculatio precox al sesso. Esattamente come i film di Gabriele (ma volendo pure di Silvio), i Vini Muccino funzionano così: li bevi, sembra che ti piacciono. Poi però, dopo tre secondi, li hai già dimenticati. Come L’ultimo bacio.
Il Fatto Quotidiano, 28 dicembre 2012
(Questo articolo, come quello di ieri su MasterChef Italia, è uscito nella versione cartacea de Il Fatto Quotidiano. I lettori dei miei libri sul vino, nonché di questo blog, lo troveranno in buona parte già noto. Ma i lettori del Fatto, di solito, non leggono articoli sul vino, argomento di cui non trattiamo quasi mai).
Le cantine nascoste (Blue, maggio 2012)
mercoledì, Maggio 23rd, 2012Pubblico qui l’articolo che mi ha dedicato Blue nel numero di maggio 2012.
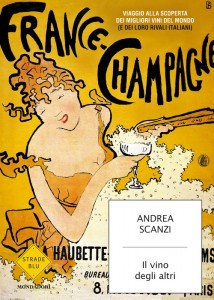 “Sfrontato, colto, irriverente. Mai banale. Controcorrente e al tempo stesso divulgativo. Iconoclasta più per carattere che per convinzione. Andrea Scanzi è così, prendere o lasciare. Blogger, opinionista del “Fatto Quotidiano”, ora anche autore teatrale, nella stessa conversazione può passare con sorprendente agilità dal tennis al motociclismo, dalla musica alla politica, a Gaber, che in questi mesi sta portando in giro per l’Italia con uno spettacolo da lui scritto e interpretato.
“Sfrontato, colto, irriverente. Mai banale. Controcorrente e al tempo stesso divulgativo. Iconoclasta più per carattere che per convinzione. Andrea Scanzi è così, prendere o lasciare. Blogger, opinionista del “Fatto Quotidiano”, ora anche autore teatrale, nella stessa conversazione può passare con sorprendente agilità dal tennis al motociclismo, dalla musica alla politica, a Gaber, che in questi mesi sta portando in giro per l’Italia con uno spettacolo da lui scritto e interpretato.Fenomenologia semiseria del vino-appassionato
domenica, Aprile 1st, 2012 Vinitaly, dopo la quarantaseiesima edizione, fa festa. Più di 140mila visitatori in quattro giorni. Tutti contenti, tranne chi si è trovato a lungo cristalizzato nel traffico di Verona. In una sorta di triangolo delle Bermuda, tra il 24 e il 28 marzo sono andati in scena – a pochi chilometri di distanza – la grandeur di Vinitaly e le manifestazioni rivali: Vini Veri a Cerea, VinNatur a Villa Favorita. Cinquanta euro (45 online) per un giornaliero a Vinitaly, 20 per i raduni degli alternativi di Enolandia. Da una parte tutto e il suo contrario, dall’altra la resistenza di chi si ostina a far vino nel rispetto quasi didascalico della tradizione.
Vinitaly, dopo la quarantaseiesima edizione, fa festa. Più di 140mila visitatori in quattro giorni. Tutti contenti, tranne chi si è trovato a lungo cristalizzato nel traffico di Verona. In una sorta di triangolo delle Bermuda, tra il 24 e il 28 marzo sono andati in scena – a pochi chilometri di distanza – la grandeur di Vinitaly e le manifestazioni rivali: Vini Veri a Cerea, VinNatur a Villa Favorita. Cinquanta euro (45 online) per un giornaliero a Vinitaly, 20 per i raduni degli alternativi di Enolandia. Da una parte tutto e il suo contrario, dall’altra la resistenza di chi si ostina a far vino nel rispetto quasi didascalico della tradizione.
Il vino è in crisi, ma avamposti e simulacri resistono. Dissesti economici ed etilometri selvaggi hanno ridimensionato il consumo perfino in Italia: nel 2010 a bere vino era il 53.3 (quotidianamente il 24.1%). Crescono gli adepti della birra (45.9%), anche grazie alla moda dei microbirrifici artigianali. La fascia di vino più florida è quella sopra le 5 euro (il prezzo più gettonato è 9.60 a bottiglia). Vini più venduti, Lambrusco e Chianti, in ascesa Prosecco e Vermentino.
Vinitaly (e derivati) offrono una visuale esauriente della stirpe umana. Basta osservare gli avventori che si avvicinano, ora trasfigurati dall’adorazione e ora obnubilati dalla diffidenza, ai banchi d’assaggio. Parafrasando il mai troppo ricordato Douglas Adams, ciò che tali rassegne offrono è una singolare Guida galattica per enostoppisti.
 C’è il “Bulimico”, ovvero colui che frequenta il Vinitaly perché una volta entrato può trangugiare tutto ciò che vuole. E’ un compulsivo, più che un appassionato, perennemente dentro la canzone di Capossela che parla di vampiri nella vigna e sottrattor nella cucina. A fine serata lo incrocerai devastato dall’alcol, meno lucido di Robinho sotto porta. Altra stirpe numerosa è quella del “Pipìdigattista”. Forse è sommelier e forse ha sbirciato “Gusto” su Tg5, ma questo gli è sufficiente per lanciarsi in degustazioni roboanti: non beve per piacere, ma per farsi vedere – e sentire – dagli altri. E’ in grado di riscontrare sentori insondabili: se berrà Sauvignon dirà che “percepisce echi di pipì di gatto”, se deglutirà Cabernet Franc azzarderà un “bosso” (che non sa cos’è), se si imbatterà in un Barolo sparerà un “goudron frammisto a cherosene con idrocarburi”. Il “Pipìdigattista” è la versione reale dell’imitazione del sommelier di Antonio Albanese, solo che non fa ridere.
C’è il “Bulimico”, ovvero colui che frequenta il Vinitaly perché una volta entrato può trangugiare tutto ciò che vuole. E’ un compulsivo, più che un appassionato, perennemente dentro la canzone di Capossela che parla di vampiri nella vigna e sottrattor nella cucina. A fine serata lo incrocerai devastato dall’alcol, meno lucido di Robinho sotto porta. Altra stirpe numerosa è quella del “Pipìdigattista”. Forse è sommelier e forse ha sbirciato “Gusto” su Tg5, ma questo gli è sufficiente per lanciarsi in degustazioni roboanti: non beve per piacere, ma per farsi vedere – e sentire – dagli altri. E’ in grado di riscontrare sentori insondabili: se berrà Sauvignon dirà che “percepisce echi di pipì di gatto”, se deglutirà Cabernet Franc azzarderà un “bosso” (che non sa cos’è), se si imbatterà in un Barolo sparerà un “goudron frammisto a cherosene con idrocarburi”. Il “Pipìdigattista” è la versione reale dell’imitazione del sommelier di Antonio Albanese, solo che non fa ridere.
Nelle rassegne alternative, la tipologia più comune è il “Khomeinista”. Si approccia al vino col gusto sbarazzino di chi, integralista sino al midollo, ascolta solo Ornette Coleman, legge giusto Fichte e guarda unicamente Kiarostami (in lingua originale e senza sottotitoli, sia chiaro). Il Khomeinista odia la barrique come Belpietro il profilo greco e, ogni volta che si trova davanti un produttore, lo tempesta con domande astruse: “Fa uso di lieviti indigeni?”, “Effettua chiarifiche?”, “Cosa ne pensa dell’acidità volatile?”. L’unica risposta possibile sarebbe un “Prematurata la supercazzola”, ma sfortunatamente nessuno ha la premura di pronunciarla.
La Guida galattica per enostoppisti contempla tante altre specie. I “Guidofili”, ad esempio: di vino sanno poco, ma hanno imparato a memoria tutte le guide in commercio. Ricordano ogni etichetta premiata con Tre Bicchieri, chiocciolina SlowWine e Cinque Grappoli, vantando la capacità mnemonica di Veltroni quando snocciola l’album figurine Panini 1972/73. Il Guidofilo si fida ciecamente delle guide, non sapendo – come ama ricordare Gianni Mura – che “guida” non è per caso anagramma di “giuda”. Il “Saputello” è colui che, quando degusta, deve far vedere che ce l’ha più lungo (il naso): se quello accanto ha notato tre profumi, lui ne citerà quattro. Tiè. Al Vinitaly furoreggia poi la “Pin Up del vino”. Di solito è una povera ragazzotta, neanche sempre bella, che staziona in tacco 15 per obbligarti a ingurgitare il rosato infimo del produttore che la paga: quando la Pin Up osa avventurarsi in disamine tecniche del vino, risulta convincente come Madama Fornero quando parla di articolo 18.
La specie più presente è però un’altra: lo “Sputatore”. Un po’ per non finire ciucchi dopo dieci minuti e un po’ perché spergiurano che il vino si può degustare anche senza ingoiare, ogni banco di assaggio contempla una temibilissima sputacchiera. La quale, di rado svuotata con solerzia, assume presto le sembianze di un blob vermiglio dotato di vita propria. In una memorabile scena di Sideways, Paul Giamatti ne beveva il contenuto. Nella realtà non capita. In compenso è tutto un profluvio di scatarrate, gargarismi e florilegi salivari. Se un alieno, per somma (sua) disgrazia, cadesse sul pianeta Terra proprio durante il Vinitaly, si convincerebbe che gli umani sono dei semi-minorati con gestualità teatrale, suoni primordiali e materia rossastra in perenne uscita dalla bocca. Un’immagine curiosa, e forse eccessiva, ma non poi così fuorviante.
(articolo uscito il 30 marzo 2012 ne Il Fatto Quotidiano. Chi ha letto Elogio dell’invecchiamento, troverà più di qualche eco del capitolo “Guida galattica per enostoppisti“).
 C’è un momento, in apparenza irrilevante e sempre sfuggente, in cui la tipicità diventa parodia. E la stranezza sconfina nella caricatura. La seconda edizione di Masterchef Italia è finita giovedì sera. Ascolti buoni, 3.05% di share. Tormentoni in Rete, liveblogging (instancabile quello di Dissapore.it). Uomini e donne che cinguettano giulivi su rapanelli mistici e “aquiloni di tiramisù rivisitato” (peccato che non abbiano visitato, e bene, anche chi gli ha dato quel nome). La cifra di Masterchef è l’esagerazione. Di tutto: dei tre ducetti, compiaciuti in una recita reiterata che rende l’imitazione di Maurizio Crozza (“Vuoi che muoro?”) perfino benevola per quanto riuscita. Dei concorrenti sull’orlo di una crisi di nervi, in grado di esultare per una quiche lorraine come neanche Tardelli-Munch nell’82. E di un format sempre più esasperato ma dalle uova d’oro, tanto che si pensa a un format per concorrenti junior (all’estero c’è già).
C’è un momento, in apparenza irrilevante e sempre sfuggente, in cui la tipicità diventa parodia. E la stranezza sconfina nella caricatura. La seconda edizione di Masterchef Italia è finita giovedì sera. Ascolti buoni, 3.05% di share. Tormentoni in Rete, liveblogging (instancabile quello di Dissapore.it). Uomini e donne che cinguettano giulivi su rapanelli mistici e “aquiloni di tiramisù rivisitato” (peccato che non abbiano visitato, e bene, anche chi gli ha dato quel nome). La cifra di Masterchef è l’esagerazione. Di tutto: dei tre ducetti, compiaciuti in una recita reiterata che rende l’imitazione di Maurizio Crozza (“Vuoi che muoro?”) perfino benevola per quanto riuscita. Dei concorrenti sull’orlo di una crisi di nervi, in grado di esultare per una quiche lorraine come neanche Tardelli-Munch nell’82. E di un format sempre più esasperato ma dalle uova d’oro, tanto che si pensa a un format per concorrenti junior (all’estero c’è già). La puntata finale ha ricalcato le precedenti. Il “carramba” stantio dei concorrenti eliminati.
La puntata finale ha ricalcato le precedenti. Il “carramba” stantio dei concorrenti eliminati. 
 “Mi sento morta: devo fare la besciamella a Barbieri”. Daiana, casalinga 53enne di Follonica, è colma d’angoscia. Si avvicina al banco degli chef come un vitello al patibolo. Si fa il segno della croce, ha gli occhi lucidi e va incontro al martirio. I 18 finalisti della seconda edizione di Master Chef Italia sono tutti così. Terrorizzati dai tre semidei, molto più degli aspiranti manager di fronte al “boss” Flavio Briatore in The Apprentice.
“Mi sento morta: devo fare la besciamella a Barbieri”. Daiana, casalinga 53enne di Follonica, è colma d’angoscia. Si avvicina al banco degli chef come un vitello al patibolo. Si fa il segno della croce, ha gli occhi lucidi e va incontro al martirio. I 18 finalisti della seconda edizione di Master Chef Italia sono tutti così. Terrorizzati dai tre semidei, molto più degli aspiranti manager di fronte al “boss” Flavio Briatore in The Apprentice. Ivan, umile e incolpevole commesso siciliano di 35 anni. Lo irridono tutti. Anzitutto Cracco, che non esce mai dal personaggio: tiene le braccia conserte e sfoggia lo sguardo pseudo-duro di un Christopher Lambert dopo una lieve colica renale: “Quanti anni hai? 20? Si vede da come cucini”; “Te l’hanno detto che esiste il sale?”; “Lei non sa nulla del fagiolo zolfino. Vada ad informarsi”. A MasterChef vita e morte sono concetti relativi: la trascendenza – il terzo occhio – è saper tagliare le cipolle alla giuliana. L’unica certezza è che la besciamella non deve avere grumi. Se sbagli roux sei fottuto. Sei fuori. Addio grembiule e sogni di gloria.
Ivan, umile e incolpevole commesso siciliano di 35 anni. Lo irridono tutti. Anzitutto Cracco, che non esce mai dal personaggio: tiene le braccia conserte e sfoggia lo sguardo pseudo-duro di un Christopher Lambert dopo una lieve colica renale: “Quanti anni hai? 20? Si vede da come cucini”; “Te l’hanno detto che esiste il sale?”; “Lei non sa nulla del fagiolo zolfino. Vada ad informarsi”. A MasterChef vita e morte sono concetti relativi: la trascendenza – il terzo occhio – è saper tagliare le cipolle alla giuliana. L’unica certezza è che la besciamella non deve avere grumi. Se sbagli roux sei fottuto. Sei fuori. Addio grembiule e sogni di gloria. in Beverly Hills. Un pittore di Como, Maurizio, rivela che “questo piatto non l’ho cucinato io ma il mio me negativo”. Se Basaglia passasse di lì, avrebbe forse dei ripensamenti. E poi c’è Regina, studentessa dai poteri divinatori: “C’è chi sussurra ai cavalli. Io lascio che gli ingredienti mi parlino. La prima a farlo è stata la rana pescatrice: mi ha detto lei che dovevo cucinarla così”. Roba che neanche Maccio Capatonda nella parodia de Il sesto senso.
in Beverly Hills. Un pittore di Como, Maurizio, rivela che “questo piatto non l’ho cucinato io ma il mio me negativo”. Se Basaglia passasse di lì, avrebbe forse dei ripensamenti. E poi c’è Regina, studentessa dai poteri divinatori: “C’è chi sussurra ai cavalli. Io lascio che gli ingredienti mi parlino. La prima a farlo è stata la rana pescatrice: mi ha detto lei che dovevo cucinarla così”. Roba che neanche Maccio Capatonda nella parodia de Il sesto senso.